[:en] A Dofa, improbabile emirato di una ben più concreta penisola araba, domina il paradosso: unica autentica ricchezza del regno è, di fatto, la sua assoluta indigenza. Emblema di questa condizione felice è il traliccio di una torre di trivellazione, abbandonato ad arrugginirsi al sole rovente, servendo da irresistibile richiamo per i giochi di una torma di bambini cenciosi e irridenti. Una ferrigna cicatrice lasciata al suolo da una torma di assetati speculatori, avvoltoi calati nell’assolato e desertico principato alla affannosa ricerca di quell’oro nero che ha fatto la “fortuna” di tanti paesi limitrofi. Una corsa finita nel nulla della sabbia ostile di un deserto che, a differenza di tanti altri, non nasconde nessuna sorpresa.
A Dofa, improbabile emirato di una ben più concreta penisola araba, domina il paradosso: unica autentica ricchezza del regno è, di fatto, la sua assoluta indigenza. Emblema di questa condizione felice è il traliccio di una torre di trivellazione, abbandonato ad arrugginirsi al sole rovente, servendo da irresistibile richiamo per i giochi di una torma di bambini cenciosi e irridenti. Una ferrigna cicatrice lasciata al suolo da una torma di assetati speculatori, avvoltoi calati nell’assolato e desertico principato alla affannosa ricerca di quell’oro nero che ha fatto la “fortuna” di tanti paesi limitrofi. Una corsa finita nel nulla della sabbia ostile di un deserto che, a differenza di tanti altri, non nasconde nessuna sorpresa.
Samantar, il protagonista di questo intrigante romanzo di Albert Cossery, “Ambizone nel deserto”, pubblicato in Italia dalle Edizioni Spartaco, assomiglia parecchio al suo autore. Indolente filosofo dei vicoli sovraffollati della città vecchia, ha una perniciosa attrazione per la sensualità scatenata e suadente delle adolescenti, una predisposizone oziosa alle fantasticherie indotte dall’haschish e un’amore assoluto per il suo paese, la cui inguaribile miseria ne fa paradossalmente un’isola felice, completamente esclusa dalle tentazioni della modernità che ha così profondamente sconvolto la vita della penisola grazie alla pioggia incessante dei petrodollari. Dofa non interessa a nessuno, non ha nulla da dire al mondo della finanza e in nessun modo può attrarre gli sguardi cupidi della superpotenza che domina i giochi del mondo.
In cambio di tanta “sfortuna”, i sudditi del vecchio emiro, oberato dai debiti, vivono una vita totalmente dedita alla “paresse”, povera di orpelli ma ricca di relazioni, in cui l’assenza di beni scoraggia ogni possibile aggressività, mentre amplifica a dismisura sentimenti “obsoleti” quali l’amore, l’amicizia e la solidarietà. Il tempo, a Dofa, scorre a rilento, scandito dai raggi arroventati di un sole impietoso, a cui offrono sicuro riparo l’ombra dei caffè, la frescura dei cortili e la chioma delle palme in riva ad un mare di una purezza trascendente.
Scritto nel 1984, ambientato come sempre nel favoloso oriente dei suoi ricordi, questo romanzo rivela quanta lucidità si nasconda nell’apparente semplicità dello stile di Cossery. E pure quanta preveggenza, visto che uno dei protaginisti della vicenda, l’orco pentito della favola, si chiama non a caso Bin Kadem, con riferimento nemmeno troppo oscuro a una cronaca ancora di là da venire. Sarà costui a scatenare una improbabile sommossa rivoluzionaria, pilotata dall’alto e volta a riportare Dofa nella modernità, trasformandola nell’innesco che dovrebbe accendere le polveri dell’intera penisola araba. Il boato delle bombe scuote la pace dell’emirato e strappa il buon Samantar dalle braccia della sua amata quindicenne, impegnandolo in una serrata ricerca di colpevoli e mandanti, nel disperato tentativo di impedire che il tranquillo emirato venga per sempre travolto nella spirale perversa della modernità.
Ritorna in questa mirabile storia la dicotomia insanabile già protagonista di un altro notevole racconto di Cossery, “La violenza e il riso”, laddove a scontrarsi sono due modalità contrapposte di reagire al sopruso. Cossery non si fa illusioni sul mondo, sa che è dominato da impostori, che le lusinghe offerte nelle sue vetrine sono soltanto scintillanti inganni, miserabili consolazioni per lenire la sete di giustizia, aborre, come ha fatto coerentemente per tutta la vita, il fascino della “velocità”, della corsa incessante all’accumulo, il cui unico antidoto sembra il perdersi lento nel girovagare senza meta dei suoi protagonisti. Ma sa anche, altrettanto bene, che la violenza, pur se inevitabilmente e dolorosamente sollecitata dalle ferite lancinanti dell’ingiustiza, non è la soluzione. Il prendersi troppo sul serio porta inevitabilmente a prendere troppo seriamente le imposture del potere. La lotta senza tregua infonde pure qualche ferita mortale, ma di fatto finisce paradossalmente per rafforzare proprio quello che vorrebbe distruggere.
Il rischio in agguato è però l’acquiescenza. C’è un personaggio, nel romanzo, che rapprenta bene questo dilemma, è il cantante di strada Hicham, a cui Samantar è profondamente devoto: sarà lui a temere che la lotta dell’ amico in difesa dell’estraneità di Dofa al mondo equivalga all’accetazione passiva di uno statu quo che condanna i poveri a un’eterna miseria senza speranza. L’indignazione lo porta a simpatizzare per la causa dei misteriosi ribelli, senza minimamenta accorgersi che anche questa rivolta rappresenta alla fine soltanto un’ulteriore faccia dell’impostura globale. Sarà la fredda logica del protagonista a disvelare l’arcano: nel mondo fittizio della politica il messaggio subliminare tende a invischiare tutti nelle sue false contrapposizioni, e anche i rivoltosi, nella loro furia impotente, finiscono per far parte del gioco universale e, inevitabilmente, a confermarlo. Unica via d’uscita, allora, l’ironia disincantata, la risata che vi seppellirà, il distacco imposto dall’occhiata feroce che coglie il ridicolo anche nella ritualità più paludata, il riso che è la vera arma letale capace di impaurire il re nudo.
Cossery, come il protagonista del romanzo, ama il mondo e gli uomini, ha dedicato la sua impareggiabile e pigra esistenza all’osservazione partecipata dei suoi simili, sa essere aperto agli stimoli anche più vaghi, gli basta un tavolo di caffè per cogliere tutti i tesori che gli scorrono innanzi. Ma sa anche, magistralmente, sfuggire ogni subdola tentazione che invita ad invischiarsi nel mondo delle cose più che in quello degli esseri. Questo dandy impeccabile, egiziano di origine, ma singolarmente proteso come un ponte surreale tra oriente e occidente, vissuto per quasi tutta la vita in una stanza dell’hotel Louisiane a Parigi, amava vantarsi di poter racchiudere in una valigia tutti i suoi averi, pronto a partire al minimo cenno della fortuna. Etraneo al mondo degli orpelli per essere più profondamente avvinto dalla sfera delle esistenze, è un critico gentile ma a suo modo feroce delle depravazioni della contemporaneità. I suoi libri hanno la leggiadria di un apologo, la serenità di una favola orientale, ma, a leggere tra le righe, la causticità bruciante di una parabola disincantata e suadente.[:it]
 A Dofa, improbabile emirato di una ben più concreta penisola araba, domina il paradosso: unica autentica ricchezza del regno è, di fatto, la sua assoluta indigenza. Emblema di questa condizione felice è il traliccio di una torre di trivellazione, abbandonato ad arrugginirsi al sole rovente, servendo da irresistibile richiamo per i giochi di una torma di bambini cenciosi e irridenti. Una ferrigna cicatrice lasciata al suolo da una torma di assetati speculatori, avvoltoi calati nell’assolato e desertico principato alla affannosa ricerca di quell’oro nero che ha fatto la “fortuna” di tanti paesi limitrofi. Una corsa finita nel nulla della sabbia ostile di un deserto che, a differenza di tanti altri, non nasconde nessuna sorpresa.
A Dofa, improbabile emirato di una ben più concreta penisola araba, domina il paradosso: unica autentica ricchezza del regno è, di fatto, la sua assoluta indigenza. Emblema di questa condizione felice è il traliccio di una torre di trivellazione, abbandonato ad arrugginirsi al sole rovente, servendo da irresistibile richiamo per i giochi di una torma di bambini cenciosi e irridenti. Una ferrigna cicatrice lasciata al suolo da una torma di assetati speculatori, avvoltoi calati nell’assolato e desertico principato alla affannosa ricerca di quell’oro nero che ha fatto la “fortuna” di tanti paesi limitrofi. Una corsa finita nel nulla della sabbia ostile di un deserto che, a differenza di tanti altri, non nasconde nessuna sorpresa.
Samantar, il protagonista di questo intrigante romanzo di Albert Cossery, “Ambizone nel deserto”, pubblicato in Italia dalle Edizioni Spartaco, assomiglia parecchio al suo autore. Indolente filosofo dei vicoli sovraffollati della città vecchia, ha una perniciosa attrazione per la sensualità scatenata e suadente delle adolescenti, una predisposizone oziosa alle fantasticherie indotte dall’haschish e un’amore assoluto per il suo paese, la cui inguaribile miseria ne fa paradossalmente un’isola felice, completamente esclusa dalle tentazioni della modernità che ha così profondamente sconvolto la vita della penisola grazie alla pioggia incessante dei petrodollari. Dofa non interessa a nessuno, non ha nulla da dire al mondo della finanza e in nessun modo può attrarre gli sguardi cupidi della superpotenza che domina i giochi del mondo.
In cambio di tanta “sfortuna”, i sudditi del vecchio emiro, oberato dai debiti, vivono una vita totalmente dedita alla “paresse”, povera di orpelli ma ricca di relazioni, in cui l’assenza di beni scoraggia ogni possibile aggressività, mentre amplifica a dismisura sentimenti “obsoleti” quali l’amore, l’amicizia e la solidarietà. Il tempo, a Dofa, scorre a rilento, scandito dai raggi arroventati di un sole impietoso, a cui offrono sicuro riparo l’ombra dei caffè, la frescura dei cortili e la chioma delle palme in riva ad un mare di una purezza trascendente.
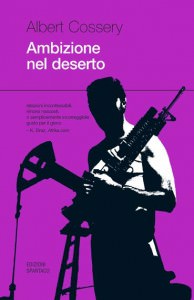 Scritto nel 1984, ambientato come sempre nel favoloso oriente dei suoi ricordi, questo romanzo rivela quanta lucidità si nasconda nell’apparente semplicità dello stile di Cossery. E pure quanta preveggenza, visto che uno dei protaginisti della vicenda, l’orco pentito della favola, si chiama non a caso Bin Kadem, con riferimento nemmeno troppo oscuro a una cronaca ancora di là da venire. Sarà costui a scatenare una improbabile sommossa rivoluzionaria, pilotata dall’alto e volta a riportare Dofa nella modernità, trasformandola nell’innesco che dovrebbe accendere le polveri dell’intera penisola araba. Il boato delle bombe scuote la pace dell’emirato e strappa il buon Samantar dalle braccia della sua amata quindicenne, impegnandolo in una serrata ricerca di colpevoli e mandanti, nel disperato tentativo di impedire che il tranquillo emirato venga per sempre travolto nella spirale perversa della modernità.
Scritto nel 1984, ambientato come sempre nel favoloso oriente dei suoi ricordi, questo romanzo rivela quanta lucidità si nasconda nell’apparente semplicità dello stile di Cossery. E pure quanta preveggenza, visto che uno dei protaginisti della vicenda, l’orco pentito della favola, si chiama non a caso Bin Kadem, con riferimento nemmeno troppo oscuro a una cronaca ancora di là da venire. Sarà costui a scatenare una improbabile sommossa rivoluzionaria, pilotata dall’alto e volta a riportare Dofa nella modernità, trasformandola nell’innesco che dovrebbe accendere le polveri dell’intera penisola araba. Il boato delle bombe scuote la pace dell’emirato e strappa il buon Samantar dalle braccia della sua amata quindicenne, impegnandolo in una serrata ricerca di colpevoli e mandanti, nel disperato tentativo di impedire che il tranquillo emirato venga per sempre travolto nella spirale perversa della modernità.
Ritorna in questa mirabile storia la dicotomia insanabile già protagonista di un altro notevole racconto di Cossery, “La violenza e il riso”, laddove a scontrarsi sono due modalità contrapposte di reagire al sopruso. Cossery non si fa illusioni sul mondo, sa che è dominato da impostori, che le lusinghe offerte nelle sue vetrine sono soltanto scintillanti inganni, miserabili consolazioni per lenire la sete di giustizia, aborre, come ha fatto coerentemente per tutta la vita, il fascino della “velocità”, della corsa incessante all’accumulo, il cui unico antidoto sembra il perdersi lento nel girovagare senza meta dei suoi protagonisti. Ma sa anche, altrettanto bene, che la violenza, pur se inevitabilmente e dolorosamente sollecitata dalle ferite lancinanti dell’ingiustiza, non è la soluzione. Il prendersi troppo sul serio porta inevitabilmente a prendere troppo seriamente le imposture del potere. La lotta senza tregua infonde pure qualche ferita mortale, ma di fatto finisce paradossalmente per rafforzare proprio quello che vorrebbe distruggere.
Il rischio in agguato è però l’acquiescenza. C’è un personaggio, nel romanzo, che rapprenta bene questo dilemma, è il cantante di strada Hicham, a cui Samantar è profondamente devoto: sarà lui a temere che la lotta dell’ amico in difesa dell’estraneità di Dofa al mondo equivalga all’accetazione passiva di uno statu quo che condanna i poveri a un’eterna miseria senza speranza. L’indignazione lo porta a simpatizzare per la causa dei misteriosi ribelli, senza minimamenta accorgersi che anche questa rivolta rappresenta alla fine soltanto un’ulteriore faccia dell’impostura globale. Sarà la fredda logica del protagonista a disvelare l’arcano: nel mondo fittizio della politica il messaggio subliminare tende a invischiare tutti nelle sue false contrapposizioni, e anche i rivoltosi, nella loro furia impotente, finiscono per far parte del gioco universale e, inevitabilmente, a confermarlo. Unica via d’uscita, allora, l’ironia disincantata, la risata che vi seppellirà, il distacco imposto dall’occhiata feroce che coglie il ridicolo anche nella ritualità più paludata, il riso che è la vera arma letale capace di impaurire il re nudo.
Cossery, come il protagonista del romanzo, ama il mondo e gli uomini, ha dedicato la sua impareggiabile e pigra esistenza all’osservazione partecipata dei suoi simili, sa essere aperto agli stimoli anche più vaghi, gli basta un tavolo di caffè per cogliere tutti i tesori che gli scorrono innanzi. Ma sa anche, magistralmente, sfuggire ogni subdola tentazione che invita ad invischiarsi nel mondo delle cose più che in quello degli esseri. Questo dandy impeccabile, egiziano di origine, ma singolarmente proteso come un ponte surreale tra oriente e occidente, vissuto per quasi tutta la vita in una stanza dell’hotel Louisiane a Parigi, amava vantarsi di poter racchiudere in una valigia tutti i suoi averi, pronto a partire al minimo cenno della fortuna. Estraneo al mondo degli orpelli per essere più profondamente avvinto dalla sfera delle esistenze, è un critico gentile ma a suo modo feroce delle depravazioni della contemporaneità. I suoi libri hanno la leggiadria di un apologo, la serenità di una favola orientale, ma, a leggere tra le righe, la causticità bruciante di una parabola disincantata e suadente.
[:]